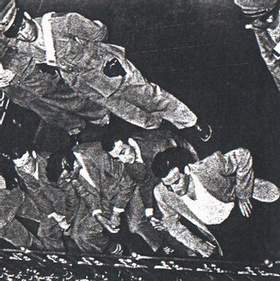Roma, venerdì 15 dicembre 1950; in viale Trastevere, alle ore 16 circa, quattro giovani entrano nell'agenzia 3 del Banco di Sicilia. Gli impiegati li guardano sospettosi: il freddo a Roma non è così intenso da giustificare quelle sciarpe tirate in su a coprire metà viso. E' un attimo, da sotto i cappotti spuntano i mitra: "Alte le mani! Presto!".
Ma le cose non funzionano nel verso giusto per i quattro banditi; si trovano di fronte uomini animosi che, anziché obbedire, reagiscono. Un funzionario della banca, il dottor Bonifacio, estrae da un cassetto la rivoltella e apre il fuoco, mentre il cassiere Civiletti e il fattorino Bonarico si gettano sui delinquenti e riescono anche a impossessarsi di un mitra. I banditi perdono la testa e si mettono a sparare. Un colpo a bruciapelo ferisce al ventre il cassiere, una raffica sparata a casaccio fulmina il direttore, dottor Angelucci. Il bandito che era rimasto disarmato è il primo a uscire di corsa dalla banca per raggiungere una
Fiat 1400 color avana, con targa di Torino; gli altri tre sparano ancora qualche colpo, poi raggiungono il loro complice. L'auto parte a tutto gas, vanamente inseguita dalle rivoltellate esplose dal dottor Bonifacio e dal cassiere Massi, che hanno inseguito i malviventi in strada.
Nella banca giacciono a terra il cassiere Civiletti e il direttore Angelucci; il primo verrà salvato dai chirurghi, per il secondo la corsa in ambulanza è purtroppo inutile. La polizia sequestra gli oggetti persi dai rapinatori, un mitra, una sciarpa e una valigia, per rilevare eventuali impronte ed inizia a raccogliere le testimonianze degli impiegati e dei due clienti che si trovavano in banca al momento della tragica tentata rapina.
Ma non ci vorranno indagini molto complesse per scoprire gli autori del misfatto. Il capo della banda si vantava di essere un uomo eccezionale, ma aveva commesso, come vedremo, un'incredibile leggerezza che avrebbe facilitato notevolmente il lavoro degli investigatori. E quel venerdì 15 dicembre 1950 iniziarono a suonare le campane a morto per una delle peggiori accolite di delinquenti del dopoguerra: la
banda Casaroli.
La notte del Capodanno 1993 moriva all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna un cardiopatico di 67 anni: si chiamava Paolo Casaroli. Già condannato all'ergastolo, aveva fatto quasi ventinove anni di galera, poi aveva ottenuto, nel 1979, la libertà per buona condotta. Si era stabilito a Marzabotto, nel Bolognese; si era sposato e aveva avuto un figlio. Cercava di vivere
dimenticato e in una delle pochissime interviste che aveva rilasciato dopo la sua scarcerazione aveva detto che il suo più grande desiderio era "il perdono dei tanti a cui ho fatto del male".
Dimenticare Paolo Casaroli: non è facile. In certi casi si entra nella storia, volenti o nolenti, anche se per motivi non certo onorevoli. La banda Casaroli rappresentò un fenomeno unico nella delinquenza del dopoguerra, e fu antesignana di certi miti negativi che sarebbero divenuti di moda negli anni Cinquanta, costituendo una
evoluzione rispetto a un banditismo spesso sanguinario, ma con cause e scopi in fondo elementari.
Per meglio spiegarci, diamo la parola ad un altro bandito, Ezio Barbieri, che operò a Milano tra la fine della guerra e il febbraio del 46. In un'intervista rilasciata nel '71, poco dopo la sua scarcerazione, Barbieri dichiarava: " Mi sono chiesto anch'io tante volte perché sono
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
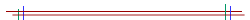 |
 |
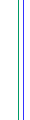 |
La banda Casaroli
rappresentò
un fenomeno unico
nella delinquenza
del dopoguerra
|
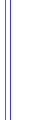 |
 |
 |
 |
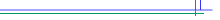 |
 |
diventato bandito, e ho pensato che l'unica ragione è stata la Milano di ventisei anni fa... sono diventato un bandito perché vedevo tutte le mattine mie madre alzarsi alle quattro e fare la coda per ore per avere mezzo chilo di pane. Milano era distrutta dalla guerra, interi quartieri erano rasi al suolo... c'era una metà della città che viveva sull'altra metà, una prendeva all'altra e l'altra subiva".
Dobbiamo naturalmente riconoscere a un ex - bandito il diritto di darsi un'immagine un po' deamicisiana, e senza dubbio la compassione per la mamma denota un animo sensibile che mal si concilia con la dimestichezza di Barbieri col mitra. Tuttavia Ezio Barbieri in quell'intervista fotografava una situazione reale: in una città ridotta alla fame non c'era da stupirsi se molti, già minati nell'anima dall'esperienza della guerra, cercavano nella violenza la risposta ai bisogni più elementari. Inoltre, aldilà dei suoi atteggiamenti da guascone e del mito
del gangster inafferrabile (favoriti anche dalla grave disorganizzazione in cui versavano le forze di polizia), Barbieri (che, va precisato, non si macchiò mai di omicidi) trasse dalle attività banditesche un guadagno che gli permise lussi modesti, anche se notevoli per l'epoca, come l'acquisto di un appartamento o il fatto di cambiare con agilità un po' di amanti. Insomma, potremmo dire che il bandito dell'immediato dopoguerra era spesso uno sbandato morale, che aveva avuto la sfortuna di conoscere la guerra, ma le cui aspirazioni erano in fondo elementari, come possono essere quelle di un fattorino che aspira a diventare capufficio e che all'improvviso pensa di aver scoperto la strada per diventarlo in fretta.
Tornando a Casaroli e ai suoi complici, vedremo invece quella che prima chiamavamo
evoluzione (in senso negativo, beninteso): quasi come bambini che vogliono tutto, e lo vogliono subito e rabbiosamente, i tre giovanotti di Bologna formano un sodalizio malato, che si dà anche delle giustificazioni ideologiche tanto fumose quanto demenziali, il tutto ammorbato da una tremenda puzza di morte. Esageriamo? Valutate voi: dei tre membri principali della banda (vi furono anche altre figure, ma del tutto marginali), due si suicidarono; il capo, Casaroli, sfuggì alla morte per pura fortuna, ma da come si comportò sembrava che la cercasse.
Certo, anche Paolo Casaroli e i suoi complici, Romano (
Romano il bello) Ranuzzi e Daniele Farris erano
figli della guerra, ma la loro tragica epopea si svolse nel 1950, quando già era esaurita la fase più acuta del banditismo postbellico. Il 5 luglio di quell'anno era stato ucciso in Sicilia il brigante dei briganti, Salvatore Giuliano. Nel Nord, formazioni criminali come la
Banda Dovunque esprimevano un nuovo tipo di delinquenza altamente organizzata e, per quanto possibile, non violenta. Il mondo tremava per la guerra in Corea, ma l'Italia era abbastanza tranquilla da potersi permettere di gioire per la maglia gialla di Fiorenzo Magni al Tour de France e la vittoria di Gino Bartali nella tappa dei Pirenei.
I primi anni in cui l'Italia si risollevava faticosamente dal disastro bellico, Casaroli, Ranuzzi e Farris li avevano trascorsi in galera e nell'anonimato; Farris dal 46 al 49, gli altri due fino al 50. Erano finiti dentro per rapine di piccolo cabotaggio, Casaroli per suo conto, Farris come reggicoda di
Romano il bello. Tre sbandati che in carcere avevano fatto amicizia e scoperto di aspirare a grandi orizzonti.
Paolo Casaroli, classe 1925. Fin da ragazzo si era mostrato rissoso, violento e, più che bugiardo, terribilmente fantasioso. La madre alcolizzata, il padre inesistente, uno zio materno morto in manicomio non rappresentavano certo l'ambito familiare più tranquillizzante. Il ragazzo era avido di letture, ma incapace di studiare in modo sistematico. Era stato mandato all'Istituto degli Artigianelli di Faenza, per imparare il mestiere di ceramista, ma ne era fuggito (1944) per arruolarsi nella Decima Mas. Poi era
 |
Il
bandito, a destra, ricoverato all'ospedale
dopo la sua ultima rapina |
arrivata la pace, ma il giovanotto aveva imparato a usare il mitra, e ci si era affezionato, finendo ben presto dentro per rapina; in galera avrebbe avuto molto tempo per dedicarsi ai suoi svaghi intellettuali, come la lettura di Jung e delle poesie di D'Annunzio.
Romano Ranuzzi, classe 1927. Alto, riccioluto, fin da giovanissimo dedicava una grande cura alla sua persona. Aveva perso la madre nel 42, aveva vivacchiato un po' con il patrigno; nel 1944 era scappato di casa e aveva tentato di arruolarsi nella Guardia Nazionale Repubblicana della Repubblica di Salò, ma non l'avevano preso perché troppo giovane. Allora aveva combattuto con i partigiani: una parte o l'altra, insomma, non faceva differenza, c'era la guerra ed era una tentazione irresistibile. Anche Romano non aveva saputo separarsi dal suo mitra dopo la fine della guerra. Quando però l'aveva impugnato per rapinare una banca in via Duca d'Aosta a Bologna usando come mezzo di fuga il tram, aveva ecceduto un po' troppo in audacia, pur con una polizia disorganizzata come quella d'allora. Ed era finito in carcere, dove aveva potuto continuare le sue letture preferite (le opere di L'ombroso), mentre a poche celle di distanza udiva Casaroli passare dal pianto al riso, cantare e recitare brani di poesie dannunziane.
Daniele Farris, classe 1927. Figlio illegittimo di una cuoca bolognese, che lo aveva avuto con un immigrato sardo, che si era limitato a riconoscerlo, poi si era eclissato. Era stato tra i primi ad arruolarsi nella Brigata Nera Mobile
Attilio Pappalardo di Bologna, che rappresentò senza dubbio un'ottima scuola: il comandante Franz Pagliani era stato estromesso dalla carica dal Duce in persona, il 28 gennaio 45, in seguito "alle violenze, torture e omicidi compiuti dalle B.N. bolognesi". Il provvedimento era stato sollecitato dal generale tedesco Von Senger und Etterlin, che aveva dichiarato: "Le B.N. compiono azioni che hanno tutte le caratteristiche di assassinii da strada...". Finita la guerra, Farris aveva vivacchiato un po' facendo lo strillone, poi era inciampato in Ranuzzi e ne era diventato il fedele gregario, seguendolo in galera.
Casaroli era ansioso di fare grandi imprese, anche se non sapeva di preciso quali; Ranuzzi lo affascinava, soprattutto per l'audacia che aveva dimostrato, Farris era una specie di cane fedele, abituato ad obbedire.
Una volta scarcerato, Paolo Casaroli ospitò a casa sua, in via San Petronio Vecchio 44, a Bologna, i due amici, con una sistemazione che subito chiariva le gerarchie: Ranuzzi aveva a disposizione una stanza nell'appartamento, per Farris invece c'era una branda nel sottotetto. I tre giovanotti, come racconterà Casaroli dopo la sua cattura, la sera facevano le ore piccole in piazza Maggiore "discutendo la filosofia di Sartre" e teorizzando nuovi ordini politici, economici, nuove definizioni morali.
Paolo Casaroli scrisse in carcere, in attesa del processo, un diario. Leggiamone alcuni istruttivi estratti. "La natura mette, di tratto in tratto, al mondo certi uomini cui assegna compiti superiori al comune; questi hanno un destino speciale: per loro è naturale che non valgano le leggi comuni, essi devono far valere la loro autorità, la loro forza e devono usarla. Quello che essi compiono, che per altri potrebbe essere crudele, per loro non è crudeltà".
Ma non c'era solo un Nietzsche mal digerito; c'erano anche strani deliri mistici: "La superiorità della mia natura si rivelò quella notte... Il mio spirito fu trascinato in un'altra spirale melodiosa, perdendosi tra le vette inaccessibili ai comuni mortali... Il tempo per me non ha valore come la vita, aspetterò; la mia vita è come un circolo senza principio e senza fine, tutta consacrata alla divina missione... "
Come poteva un uomo capace di simili svolazzi intellettuali accontentarsi di ciò che gli offriva il Comune di Bologna, una banale licenza provvisoria per una bancarella di cocomeri? Era l'estate del 50, e sarebbe stato un modo per incominciare a sbarcare il lunario in attesa di tempi migliori. Ma era poco, tremendamente poco e che figura avrebbe fatto con gli amici un superuomo, a tagliare e servire fette di cocomero? L'iconografia
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
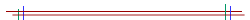 |
 |
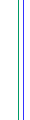 |
Il "battesimo"
della banda
Casaroli avviene
il 3 ottobre 1950...
|
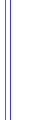 |
 |
 |
 |
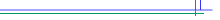 |
 |
ufficiale della banda (e prendiamola col beneficio d'inventario, perché fu sempre Casaroli a raccontarla dopo la cattura) vuole che i tre giovanotti si fossero riuniti una sera, affidando alla sorte il loro destino: Casaroli gettò in aria una scatola di cerini; a seconda di come fosse caduta per terra, sarebbero divenuti galantuomini o banditi. Di sicuro l'esaltato giovanotto si fece incidere su un braccialetto d'oro la scritta "Mamma, fu destino". Grazie a trentamila lire prestate da una delle numerose
fiamme di Romano Ranuzzi, la banda si procurò le armi, e iniziò un'attività di rapine itineranti. Le rapine erano studiate da Casaroli stesso, con meticolosità, in zone lontane da Bologna. Lombardia, Liguria, Piemonte sono le regioni che vedranno le gesta della nuova banda. Poi ci sarà Roma, e la fine.
Come rinforzo, o con funzioni di autisti o di ladri d'auto, parteciperanno alle rapine anche altri tre balordi bolognesi, Giovanni De Lucca, Giacomo Torchi e Lorenzo Ansaloni; quest'ultimo, in particolare, aveva doti di autista spericolato. Ma i tre gregari erano comunque trattati come tali: dopo le rapine ricevevano la loro parte di bottino e venivano mandati via.
Il battesimo della banda Casaroli avviene il 3 ottobre 1950, alla succursale di Binasco della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. Nella banca si trovano solo il direttore, un cassiere e un fattorino; i banditi, sotto la minaccia delle armi, li legano e poi svuotano i cassetti, ma il risultato non è granché: poco più di seicentomila lire. Oltretutto gli esordienti rapinatori rischiano di finire subito male, perché un agricoltore della zona passa con la sua auto davanti alla banca proprio mentre ne stanno uscendo gli impiegati, che erano riusciti a slegarsi e che indicano urlando una
millecento poco distante: è con quella che i banditi stanno fuggendo! L'agricoltore, Piero Sala, si mette coraggiosamente all'inseguimento dell'auto, guadagna terreno, ma nel frattempo arriva anche una pattuglia della polizia stradale: gli agenti fermano l'auto di Sala scambiandola per quella dei rapinatori. Chiarito l'equivoco, i banditi si sono già eclissati.
Seicentomila lire non sono tante, ma per l'epoca erano una somma tutt'altro che disprezzabile. Ne servivano comunque di più: accennavamo prima ad un altro famoso bandito, Ezio Barbieri, che coi primi proventi criminosi si era comprato la casa. I tre
vitelloni bolognesi conducevano invece una vita dispendiosissima, frequentando ristoranti e
night club, dove Casaroli amava presentarsi come "ingegner Muller, di Marsiglia" e discutere di letteratura, mentre guardava Farris che cercava, impacciato, di ballare e Ranuzzi, vestito elegantemente e coi capelli splendenti di brillantina, che faceva stragi di cuori col suo fascino e il suo portafoglio gonfio.
Ma, appunto, se si voleva tenere un simile
train de vie bisognava darsi da fare: ed ecco altre rapine in banca a Capitta (Genova) e a Torino. Incomincia a partire qualche colpo di pistola, ma non ci scappa né il morto né il ferito. La banda ora ha racimolato oltre sette milioni e i tre compari, radunati nella vecchia casa di Bologna, stanno studiando un altro colpo. Non sono passati neanche due mesi e mezzo dall'esordio, tutto è sempre filato via liscio, perché quindi non dovrebbe andar bene anche la prossima impresa progettata da Casaroli, ossia una rapina in banca a Roma? L'obiettivo è un'agenzia del Banco di Sicilia a Trastevere; la zona permette buone vie di fuga, di sicuro tutto andrà bene come nelle altre rapine e si potrà continuare all'infinito a sentirsi forti, invincibili, ricchi...e cosa successe a Roma, venerdì 15 dicembre del 1950, lo vedevamo in apertura. Bottino zero e una fuga precipitosa, lasciandosi alle spalle un morto e un ferito grave: ma i quattro rapinatori (al terzetto era aggregato, in quell'occasione, De Lucca) avrebbero potuto cavarsela. Nessuno
 |
Paolo
Casaroli, a sinistra in abito scuro,
condotto al processo con i suoi complici |
li aveva inseguiti. Casaroli, Ranuzzi e Farris avevano lasciato Roma in treno, De Lucca aveva avuto l'incarico di ricondurre l'auto a Bologna. E proprio la
1400 fu la trappola che incastrò la banda: Casaroli, incredibilmente, aveva preso l'auto a nolo dall'autorimessa Balboni di Bologna, e sembrava che avesse fatto il possibile per farsi notare. Aveva infatti esibito al titolare dell'autorimessa un libretto di risparmio al portatore con settecentomila lire di saldo, da lasciare in garanzia. Il Balboni, insospettito da una somma così forte in mano a uno sfaccendato, aveva chiesto consiglio a un suo conoscente, l'agente di polizia Giuseppe Tesoro; questi, conoscendo i precedenti di Casaroli, aveva suggerito al noleggiatore di rifiutare. Casaroli si era allora rivolto a un altro garage, sempre chiedendo di noleggiare una
1400; alla fine aveva ottenuto proprio l'auto che voleva, quella cioè di Balboni, perché l'altro garagista si era rivolto a quest'ultimo, non disponendo nella sua rimessa del modello richiesto.
Quando la Questura di Roma, dopo il tragico assalto in banca, aveva diramato segnalazioni a tutte le questure d'Italia, specificando che, a detta dei testimoni, i malviventi erano fuggiti a bordo di una
1400, l'agente di polizia Tesoro era andato a trovare il Balboni e aveva potuto verificare che la sua
1400, regolarmente restituita, aveva percorso un migliaio di chilometri. La cosa più ovvia, a questo punto, era convocare in questura Paolo Casaroli, pregiudicato, nullafacente, per fare quattro chiacchiere.
L'idea di fare una rapina con una macchina presa a nolo è così folle da far sorgere spontanea una domanda: Casaroli voleva mettere la polizia sulle sue tracce? Voleva rendere ancora più emozionante il gioco pazzesco in cui si era impegnato coi suoi compari? Solo lui avrebbe potuto spiegarlo, ma su questo punto non si scucì mai. Quando era ancora ricoverato, Casaroli venne intervistato da un giovane e brillante giornalista, Enzo Biagi. Il bandito, tra le altre farneticazioni, disse anche: "Non considero nulla la mia vita, e quindi non rispetto quella degli altri". Dati questi concetti (oltre agli estratti del delirante diario, che vedevamo prima), è così strano ipotizzare che volesse portare alla rovina anche sé stesso e i suoi amici?
Bologna, sabato 16 dicembre 1950, alle ore 13.40. Gli agenti di Pubblica Sicurezza Giuseppe Tesoro e Giancarlo Tonelli si portano in via San Petronio Vecchio, al numero 44. L'appartamento di Casaroli è al pianterreno, prima porta a destra nell'androne. Bussano, e viene ad aprire la sorella di Paolo. Dice di attendere un attimo, poi invita Tonelli ad entrare. Tesoro è rimasto al portone. Casaroli sta pranzando tranquillamente con Ranuzzi, Farris è invece nella sua stanzetta nel sottotetto. Tonelli conosceva già Ranuzzi, lo aveva arrestato qualche anno prima, ma non si aspettava di trovarlo lì; invita quindi entrambi a seguirlo in questura. I due si alzano dal tavolo ed estraggono fulmineamente le pistole. Il poliziotto viene disarmato, ma cerca di spaventare i due delinquenti con un bluff: "Fuori è pieno di poliziotti, dove sperate di andare?". Per tutta risposta Ranuzzi gli tira un violento pugno in faccia e scappa insieme a Casaroli. Nell'androne i due incontrano l'agente Tesoro e lo ammazzano con due colpi al cuore, poi si impadroniscono della sua pistola e continuano la fuga in strada. Giancarlo Tonelli si è riavuto in pochi istanti, è disarmato, ma non esita a lanciarsi all'inseguimento: una pallottola all'inguine lo ferma, ma ha ancora la forza di gridare: "Fermateli! Sono i banditi di Roma! Assassini!".
Gli spari e le grida hanno attirato l'attenzione di molti passanti; Casaroli e Ranuzzi, entrambi con due pistole in pugno, imboccano di corsa la via Remorsella, una laterale che porta sulla centralissima via Santo Stefano. Ora echeggiano altri spari: carabinieri, poliziotti e vigili urbani sono all'inseguimento dei due banditi, che tentano un'impossibile fuga saltando in corsa su un tram e ingiungendo al manovratore di accelerare. Questi, Gaetano Cotti, dimostrando un sangue freddo non comune, rallenta e i due allora saltano giù,
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
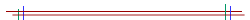 |
 |
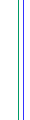 |
...Sono le ore 13.55;
la follia ha
imperversato per
un quarto d'ora che
è sembrato eterno
|
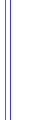 |
 |
 |
 |
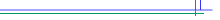 |
 |
corrono verso un parcheggio di taxi. Un commerciante, Mario Chiari, ex brigadiere dei carabinieri, tenta di fermarli gettando tra le loro gambe la bicicletta e viene freddato all'istante. Ormai Casaroli e Ranuzzi hanno completamente perso la testa. Uccidono anche un tassista, Antonio Morselli, che anziché caricarli sulla propria vettura era fuggito spaventato. Tallonati ormai da vicino dai tutori dell'ordine, i due folli pistoleri, dopo aver ferito il vigile urbano Luigi Zedda, che aveva puntato contro di loro la pistola, cercano di impadronirsi di una giardinetta di passaggio: ma la donna che è alla guida si spaventa, va a finire contro una delle colonne dei portici, e l'auto è inutilizzabile. Allora i due criminali bloccano un'Ardea, con a bordo due medici, i dottori Azzolini e Possati. Azzolini, alla guida, viene strappato fuori dall'auto, ma Casaroli e Ranuzzi non sono più in grado di connettere: non si accorgono che Azzolini ha la prontezza di estrarre le chiavi dal cruscotto, mentre Possati, spaventato, si lascia scivolare davanti al sedile di destra. Casaroli balza al posto di guida, Ranuzzi apre la portiera posteriore, e proprio in quel momento un proiettile lo raggiunge all'addome. Come riferirà poi il dottor Possati,
Romano il bello si accascia sul divano posteriore dell'Ardea, dice freddamente: "Ciao, Paolo", poi si spara un colpo in testa.
Casaroli si rende conto che non può avviare l'auto, e ne esce di corsa, sparando a casaccio, ma ormai il cerchio degli uomini della legge si è stretto: una diecina di colpi lo raggiungono e stramazza al suolo. Sono le ore 13.55; la follia ha imperversato per un quarto d'ora, solo un quarto d'ora, che è sembrato eterno. Ora è tutto finito, con un bilancio tragico: tre morti ammazzati, un suicida, due feriti gravi (il poliziotto Tonelli e il vigile Zedda) e Casaroli che giace sull'asfalto; sembra morto, e questa è la voce che subito circola per Bologna e viene anche pubblicata per errore da un giornale del pomeriggio. Ma è ancora vivo, nessuno dei colpi che lo hanno raggiunto era mortale. Viene ricoverato in ospedale, nella stessa corsia in cui si trova l'agente di polizia Giancarlo Tonelli.
E Daniele Farris? Dalla sua stanza nel sottotetto aveva sentito i primi spari, era sceso in strada, confuso tra la folla; anche a lui erano giunte le voci che i due folli pistoleri erano Ranuzzi, che si era sparato, e Casaroli, che era stato ucciso dalla polizia. Per Farris crolla tutto.
Alle ore 20 di quel tragico sabato, nel cinema Manzoni di Bologna, viene interrotta la proiezione e si accendono le luci. Si è udito uno sparo. In una poltrona di galleria c'è un giovanotto con la camicia macchiata di sangue. E' morto, stringe ancora in pugno una pistola. La polizia gli trova in tasca una carta d'identità falsa, intestata a Giuseppe Raspadori, di anni 30, e un biglietto: "La faccio finita, non per paura o vigliaccheria, ma solo perché ho il rimorso di non essere stato vicino ai miei amici e specialmente a Paolo nella sua ora estrema. Non mi pento di nulla, ho fatto tutto ciò che volevo. Paolo, mantengo la promessa, ti seguo".
Non ci volle molto a scoprire che il sedicente Raspadori era in realtà Daniele Farris, che, convinto della morte di Casaroli, si era tolto la vita. Una curiosità: Farris per falsificare il documento aveva usato il cognome della madre, Raspadori.
Dal 3 ottobre al 16 dicembre 1950: in due mesi e tredici giorni si era consumata la folle epopea della banda Casaroli. Per settantaquattro giorni i tre giovanotti avevano vissuto un'avventura frenetica, fatta di assalti, ricchezza, vita da nababbi, nuovi assalti, sangue... prevedendo tutto, salvo un adeguato piano di fuga. Probabilmente la via di fuga non era mai stata predisposta perché nessuno la desiderava. Era l'avventura il vero amore dei tre compari di Bologna, ma l'avventura intesa nel senso più negativo e malato. La velocità con cui spendevano i soldi ricavati dalle rapine non derivava, a nostro avviso, solo dal desiderio di darsi ai piaceri della bella vita: era anche un modo, più o meno conscio, di tagliarsi ogni ponte alle spalle, accelerando sempre più un'inesorabile corsa verso la morte.
La banda Casaroli, in questo senso, rappresentò l'evoluzione negativa del disastro morale della guerra. Dalla soddisfazione dei bisogni più elementari (mangiare, avere un'abitazione), di cui parlavamo innanzi, si era passati al bisogno di vivere
tutto, il più
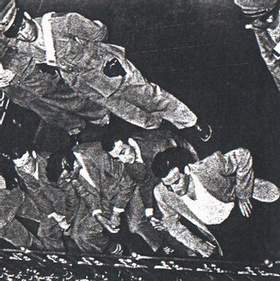 |
Una
panoramica della gabbia degli imputati
ripresa durante il processo alla banda |
velocemente possibile. La violenza, bacillo inesorabile, iniettata in povere menti semplici con la legittimazione bellica, aveva via via eroso ogni senso morale e anche lo stesso istinto di conservazione. La sfera affettiva risultava completamente stravolta: pensiamo che due suicidi, due giovani di ventitré anni che si ammazzano, legittimino questa affermazione.
L'Italia, sconcertata dal sabato di sangue di Bologna, avrebbe iniziato a conoscere la
gioventù bruciata, i
teddy boys. Pochi anni dopo i fatti di Roma e Bologna, in occasione di un processo contro un gruppo di giovani colpevoli di un tentativo di stupro contro una ragazza che, reagendo, ne aveva ucciso uno, il gesuita Padre Virgilio Rotondi, sostenendo il diritto della ragazza di difendersi, ammonì anche di non sottovalutare il dramma dei colpevoli, "ragazzi a loro volta vittime di un'oscura ossessione".
Casaroli era in ospedale, vivo, cosciente. I proiettili degli uomini della legge l'avevano ferito in dieci parti del corpo, ma aveva avuto una fortuna incredibile. Ma non era un uomo che si era lasciato alle spalle una scia di sangue, che aveva visto il suicidio di un amico (e di lì a poco avrebbe saputo anche del suicidio dell'altro fedelissimo), non era l'uomo cosciente dell'odio di un'intera città contro di lui.
Era un uomo loquace, sorridente, che aveva finalmente tutto il palcoscenico per sé. Col cappellano dell'ospedale si svolse un rapido scambio di battute. Questi, un frate cappuccino, si avvicinò al letto dove Casaroli era piantonato:
"Guarda che hai fatto? Ma non hai una madre anche tu?"
"Se sono al mondo, evidentemente ce l'ho..."
"Ma non sei dunque pentito di quello che hai fatto, a Roma e qui?"
"Adesso è troppo tardi per pensarci!".
E con quest'ultima battuta, girò le spalle al religioso, chiedendo una sigaretta a uno dei militari che lo piantonavano...
Paolo Casaroli era pazzo? Secondo gli psichiatri, sì: "schizofrenico, incostante, con incontrollabilità di contegno". Secondo i giudici, che il 30 luglio del 1953 lo condannarono all'ergastolo, era comunque capace di intendere e di volere. E' difficile dare una risposta. Di sicuro in tutto il periodo di detenzione prima del processo fece di tutto per dimostrarsi pazzo. Le accuse contro di lui erano macigni, e solo l'infermità mentale avrebbe potuto salvarlo dall'ergastolo. Scrisse anche una folle lettera a Benedetto Croce, minacciandolo di morte per la "prosopopea" con cui il filosofo aveva scritto un commento critico al trattato di pedagogia e didattica di Kant.
Se poi le mattane di Casaroli fossero funzionali ad una tattica difensiva, o fossero solo gli ultimi picchi di un esibizionismo incontrollabile, non siamo noi in grado di giudicarlo, così come non ci permettiamo di valutare la sincerità, o meno, del suo pentimento.
Abbiamo voluto rievocare queste tragiche vicende perché la cronaca alle volte diventa Storia, segna delle svolte, nel bene o nel male, nelle vicende di un paese e di un popolo.
E facciamo il nostro lavoro sempre nella testarda convinzione che leggere la Storia possa servire a migliorarci, magari avendo il coraggio di guardare la realtà che ci circonda, per capire se e come possiamo renderla migliore. Allora anche il sacrificio oscuro delle vittime di una folle mano criminale non è inutile; allora, anche, si potranno meglio prevenire quelle "oscure ossessioni" che spingono spesso gli uomini nel precipizio.